
Giuseppe Cricenti, giudice alla Corte di Cassazione, che si dedica in modo costante anche alla ricerca e all’insegnamento universitario, sembra avere le idee chiare in materia di “maternità surrogata”, come lascia presagire già dal titolo il suo ultimo saggio, “Il Mercato del ventre”. Il libro pubblicato da Rubbettino ha per sottotitolo “Il caso della maternità surrogata”.
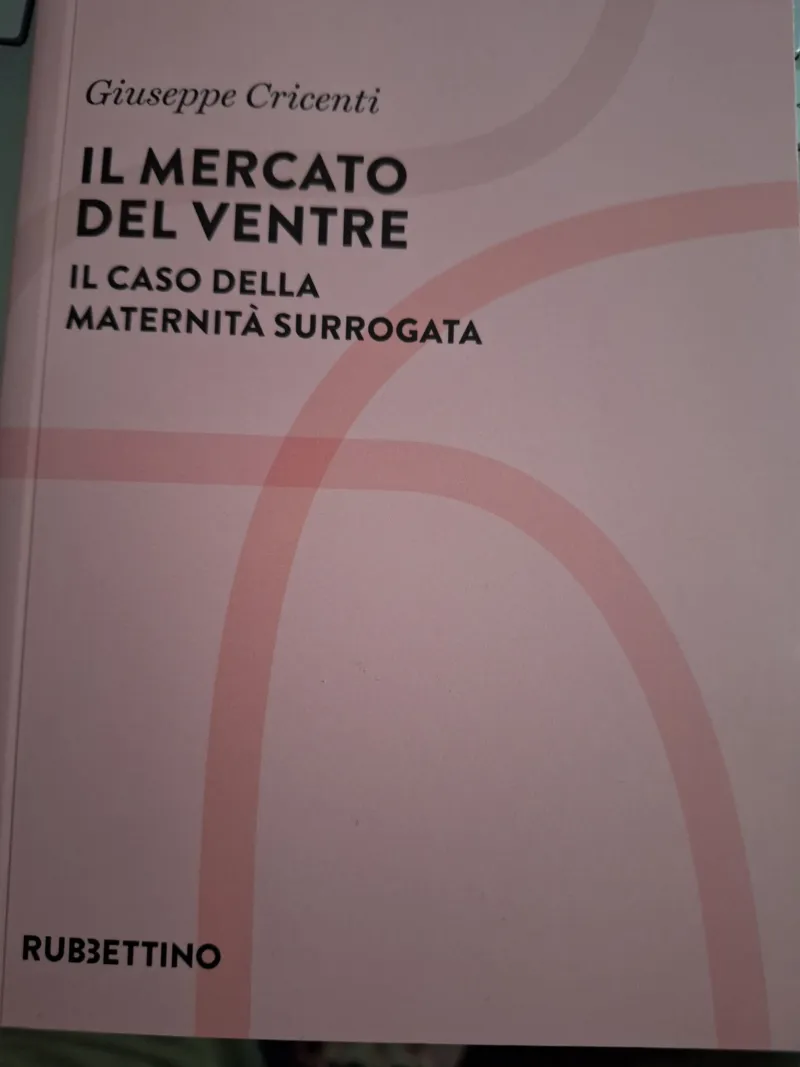
Il fenomeno del cosiddetto “utero in affitto” è descritto come un meccanismo di mercificazione della maternità, che vede prima facie coinvolti tre soggetti : una donna o una coppia che per motivi diversi non possono avere figli, nella fattispecie una donna che non può farsi carico di una gravidanza; un’altra donna che può supplire a questa carenza “prestando” o “affittando” il suo utero alla prima; un’agenzia che fa da tramite per ottenere una maternità surrogata, cioè la nascita di un bambino che non sarà della donna che lo partorisce, ma della donna o della coppia che hanno promosso tale procedimento attraverso un contratto fra le parti. Si è in presenza di un desiderio più o meno legittimo di maternità, o paternità, da una parte; di contro ci troviamo sovente di fronte ad un evidente bisogno legato a difficili condizioni economiche, quello di una donna che è disposta a gestire una gravidanza per mettere al mondo un figlio non suo in cambio di un sostegno economico. Nel mezzo, fra il desiderio, l’aspirazione alla maternità di una donna e il bisogno di un’altra, si pone come intermediaria un’agenzia che mette in relazione le due diverse esigenze in cambio di un sostanzioso compenso.
Non sfugge un dato oggettivo: secondo l’ottica su ricordata, il diritto alla maternità o alla genitorialità sembra confondersi con un meccanismo commerciale che vede tre soggetti coinvolti, tre realtà che hanno un peso economico-contrattuale assai diversificato: la donna o la coppia agiata che vuole avere un figlio attraverso un’altra donna e che deve farsi carico di una spesa che mediamente supera i centomila dollari; una donna che si presta a fare la madre in vece di un’altra e che riceve un compenso che spesso non raggiunge il 20% del budget complessivo ed infine un’agenzia mediatrice fra i desideri e i bisogni in campo, che è pure la principale beneficiaria, almeno in termini di profitto, dell’operazione. Naturalmente ai tre protagonisti della maternità surrogata se ne aggiunge un altro che, seppure non ha la capacità di far valere le sue ragioni in prima persona, deve essere considerato e tutelato: il bambino che è il fine ultimo di una maternità surrogata.
Esiste un’altra questione che l’autore de “Il mercato del ventre” sembra aver sommariamente liquidato , un’opzione che farebbe venir meno la costruzione della maternità surrogata come “mercato del ventre”, il caso in cui una donna si prestasse a fare la madre surrogante senza alcun fine economico, senza richiedere compensi o financo rimborsi per le spese a vario titolo sostenute, per spirito di pura solidarietà, semmai spinta da un sentimento di amicizia o parentela nei confronti di una donna più sfortunata. Se non c’è chi compra o chi vende un servizio, se viene meno la necessità di intermediari retribuiti, come si fa a parlare di “mercato del ventre”? Strano mercato quello in cui non si compra e non si vendono prodotti o servizi, dove la moneta non ha alcun ruolo.
Queste tematiche e diverse altre sono centrali nel libro di Cricenti e se ne è discusso lo scorso martedì a Roma, nella Sala Vittoria Colonna dell’Università Guglielmo Marconi, con la partecipazione di Maurizio Gasparri, Vicepresidente del Senato della Repubblica, della Senatrice Maria Domenica Castellone, del Deputato Marco La Carra, della magistrata Fernanda Fraioli, di Giuseppe Quintavalle Direttore Generale ASL Roma 1, del medico Antonio Magi e della psicoterapeuta Maria Rita Parsi, con interventi moderati da Filippo Caleri, giornalista del “Il Tempo”. L’iniziativa è stata curata dalla Fondazione Artemisia.
Nei vari interventi sono emersi essenzialmente gli aspetti problematici della maternità surrogata, che investono direttamente i soggetti coinvolti, non ultimo il bambino oggetto del contratto, che a volte si è ritrovato orfano ancor prima di venire al mondo, in quanto tanto la donna che si faceva carico della gestazione, che la coppia che l’aveva sollecitata, per motivi sopravvenuti si sono rifiutati di accettare come proprio il nascituro. Sono stati ricordati alcuni casi emblematici, riportati anche nel libro di Cricenti, come quello di una coppia di lesbiche sordomute che attraverso “l’utero in affitto” hanno programmato la nascita di un bambino sordomuto, ritenendo questa loro condizione non un limite, ma una interessante modalità di vita che volevano conservare anche nella loro discendenza, con una paradossale logica eugenetica.
In Italia, come ha opportunamente ricordato la Senatrice Maria Domenica Castellone, anche nella sua veste di medico e ricercatrice, la maternità surrogata è vietata dalla legge n° 40/2004 e recentemente con la legge 169/2024 si è estesa la perseguibilità del reato di gestazione per altri, anche se commessa all’estero da cittadini italiani. Perché parlarne, allora? Almeno per due motivi, emersi entrambi nella presentazione del libro di Cricenti: la maternità surrogata può aiutare delle donne che per impedimenti oggettivi non possono avere figli ad averne, attraverso procedure che garantiscano i diritti dei soggetti coinvolti, in prima istanza del nascituro e della donna che si presta alla gestazione, in una logica solidale e non commerciale. “Abbiamo bisogno di una legge che affronti la problematica nella sua rilevanza complessiva, non solo i casi limite. Se voglio aiutare una sorella gratuitamente, perché mi dovrebbe essere impedito? In Grecia o in Portogallo è possibile, attraverso percorsi di verifica capaci di tutelare tutte le parti in causa”. Così si espressa la Senatrice Castellone, che ha pure sottolineato le difficoltà e spesso i ritardi della società civile e della politica che a suo modo la rappresenta, nel recepire i cambiamenti sociali e culturali che gli sviluppi delle scienze e delle tecniche favoriscono.
Un secondo motivo per riconsiderare la questione della “maternità surrogata” si lega anche al fatto, speculare a quello appena ricordato, che le nuove tecnologie in campo medico permettono di ottenere un figlio attraverso la procedura della maternità surrogata e, come lo stesso Cricenti ha sottolineato, nessuna società rinuncia alle acquisizioni scientifiche raggiunte dalla ricerca.
Basta una legislazione punitiva per eliminare la maternità surrogata, anche quella mossa da motivazioni solidaristiche e non speculative? Forse no, essenzialmente per due ragioni: se esiste una richiesta in tal senso, spesso legittima e moralmente fondata, e per un altro verso la possibilità di soddisfarla attraverso procedimenti medici consolidati, è difficile tenere scissi i due aspetti semplicemente attraverso una normativa repressiva. Non ci si è riusciti, ad esempio, nel caso del divieto all’aborto che per anni non ha impedito il ricorso di massa all’aborto clandestino, come è stato ricordato nella discussione.
Forse sarebbe il caso non di vietare, ma di regolare, seguendo l’esempio di due Paesi dell’UE come la Grecia e il Portogallo.
Enrico Ferri, professore di Filosofia del Diritto all’Unicusano
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.
I campi obbligatori sono contrassegnati con *