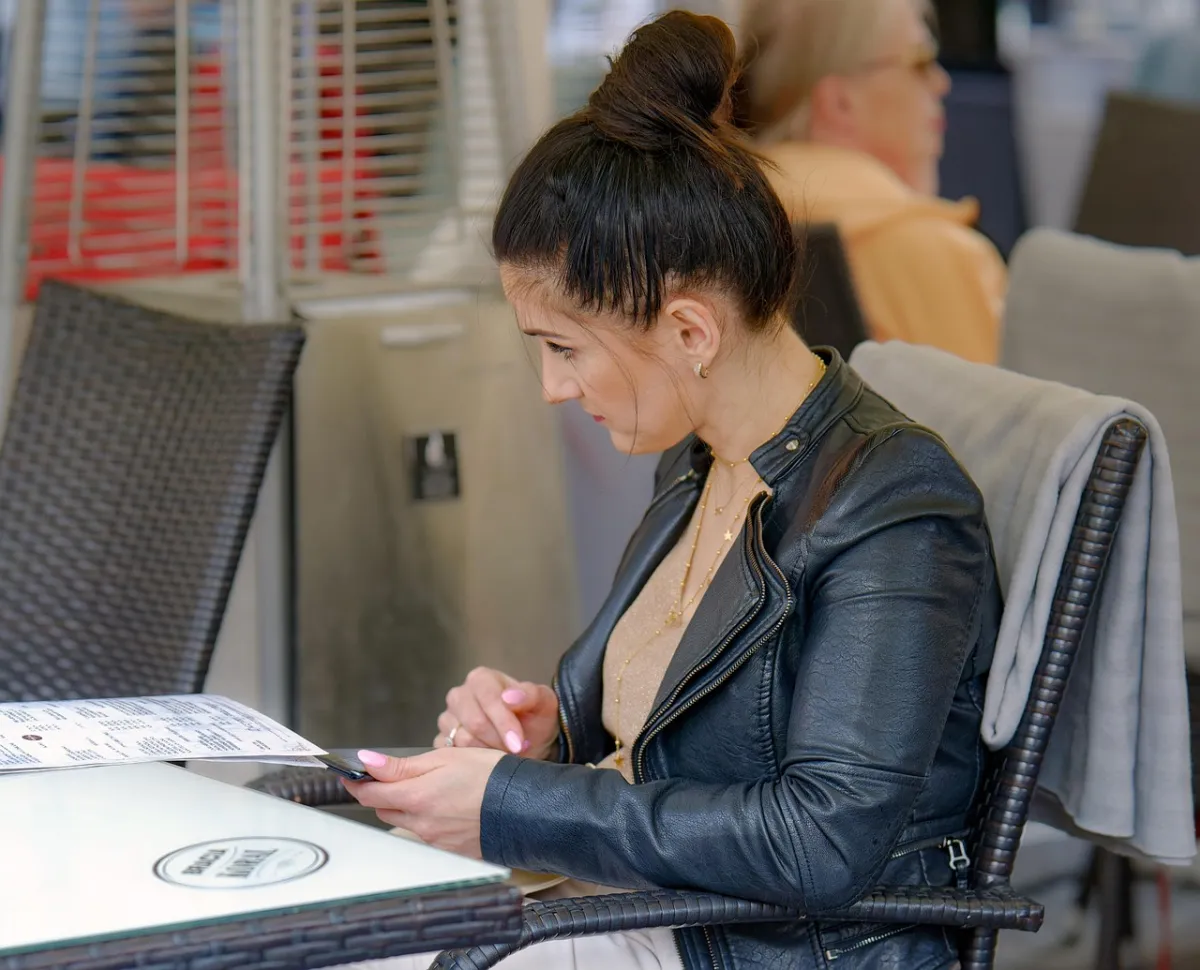
La patrimoniale mette in fuga ogni speranza: l’illusione di un risparmio utile all’equilibrio dei conti statali riaccende il turbo sulla pressione fiscale. E cresce la paura, ormai dilagante, che arrivi un’altra batosta sulle spalle degli italiani. Ma è davvero necessario introdurre una nuova imposta sulla ricchezza? Gli italiani, però, non sembrano aver imparato la lezione: già oggi paghiamo tasse e imposte che assumono forme meno riconoscibili.
Da anni molti economisti sottolineano come l’imposta di bollo sulle attività finanziarie rappresenti una forma di patrimoniale “di fatto”, applicata in modo automatico e poco percepibile. Ma come funziona davvero, quali norme la regolano e quale gettito produce alla luce degli aggiornamenti più recenti?
Su imposte e tasse si persevera. E come? Non servono grandi elaborazioni nei piani finanziari per applicare l’imposta di bollo. Il riferimento normativo è il D.P.R. 642/1972, che all’articolo 13 disciplina l’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari.
Un passaggio determinante arriva con il D.L. 201/2011, che ridefinisce la struttura dell’imposta e stabilisce l’aliquota dello 0,20% come misura ordinaria calcolata sul valore degli strumenti detenuti.
In sostanza, l’imposta non è legata al rendimento e non colpisce il reddito prodotto: viene applicata indipendentemente dalla ricchezza posseduta, semplicemente per aver istituito strumenti finanziari. Insomma, per molti versi si aggancia perfettamente alle imposte patrimoniali. È per questo che diversi analisti la considerano la principale forma patrimoniale già operativa nel sistema italiano.
Eppure continua a essere applicata nel silenzio più totale a dossier titoli, fondi comuni, obbligazioni, conti deposito e molti altri strumenti. Tutto avviene automaticamente: il calcolo viene effettuato dagli intermediari sulla base del valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso.
Il meccanismo normativo è chiaro e semplice:
aliquota dello 0,20% sulla giacenza media o sul valore a fine periodo;
applicazione automatica da parte dell’intermediario;
obbligo dovuto allo Stato, non alla banca.
Ed è proprio questa semplicità che rende l’imposta rapida da incassare e, per molti versi, invisibile agli occhi del risparmiatore medio.
La banca, in qualità di intermediario finanziario, applica il bollo in maniera diretta e senza complicazioni. Nessuna dichiarazione aggiuntiva per il contribuente, nessun adempimento extra. Il cliente più attento nota la voce in rendiconto, chiede spiegazioni e gli viene ricordato che non si tratta di una decisione della banca, ma di un’imposta dovuta allo Stato.
Nei rendiconti periodici l’imposta appare come voce separata, spesso poco evidente ma sempre presente.
Per alcuni soggetti - soprattutto non persone fisiche - è previsto un tetto massimo di 14.000 euro l’anno, mentre per i privati il prelievo resta proporzionale al valore complessivo delle attività.
Risultato: un flusso stabile e costante che, negli anni, ha assunto la funzione di una patrimoniale implicita.
Come riportato dal Sole 24 Ore, l’imposta di bollo ha portato nelle casse dello Stato oltre 9 miliardi di euro solo nell’ultimo anno. Una cifra enorme, che supera molte altre voci fiscali e dimostra come questa forma di prelievo, pur non dichiarata come patrimoniale, funzioni già come tale.
Mentre il dibattito politico torna ciclicamente sulla necessità di nuove tasse sui grandi patrimoni, il bollo continua a generare un gettito consistente e invisibile ai più, operando in secondo piano ma con effetti tangibili.
Secondo l’ultimo studio della CGIA di Mestre, pubblicato il 15 novembre 2025, le imposte classificate come “patrimoniali” dall’Ufficio Studi – IMU, imposta di bollo, bollo auto e imposta di registro – hanno garantito nel 2024 un gettito complessivo di 51,2 miliardi di euro, con una crescita del 74% negli ultimi vent’anni.
L’IMU è la voce dominante, con 23 miliardi, pari al 45% del totale. Seguono:
imposta di bollo: 8,9 miliardi
bollo auto: 7,5 miliardi
imposta di registro: 6,1 miliardi
La pressione fiscale prevista per il 2025 sale al 42,8%, mentre la stessa CGIA ricorda come l’evasione fiscale superi i 100 miliardi di euro, con livelli particolarmente elevati in Calabria, Puglia e Campania.
Per l’associazione, prima di introdurre nuove patrimoniali, occorrerebbe ridurre sprechi pubblici e contrastare seriamente l’evasione strutturale.
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.
I campi obbligatori sono contrassegnati con *